Nella storia dell’umanità e del mondo non sono rari i casi in cui si determina una profonda spaccatura fra il passato e il presente, proiettando fitte nubi sul futuro. Tempi di dolori lancinanti e insieme di slanci insperati. Certo è che da mesi stiamo vivendo un’esperienza devastante che ha messo e mette tutto in discussione. Quante volte ci siamo detti, e continuiamo a ripeterci, che non potremo più essere come prima? La risposta è legata strettamente a una profonda riflessione su come eravamo e come siamo diventati, per cercare di capire come potremo essere. Al centro di ogni pensiero dominano le immagini di corpi feriti, violati, uccisi dalla bestia invisibile che ha lacerato insieme ai corpi anche gli spiriti. Mai come in queste circostanze ci rendiamo conto che corpo e spirito sono parti inscindibili dell’essere.
La lacerazione si è prodotta in un tempo in cui il corpo occupava un posto privilegiato nel contesto di una vita egocentrica, più che mai dominata dal Narciso che alberga dentro ognuno di noi. Basta ricordare uno slogan del femminismo sessantottino: «Il corpo è mio e lo gestisco io». Era una rivendicazione soprattutto politica, ma non poteva non caratterizzare la cultura, che accanto al superamento del maschilismo (peraltro mai morto) ha prodotto anche la banalizzazione della sessualità, e quindi della corporeità.
Basta dare uno sguardo a tutta la pubblicità che esalta lo stare bene con l’aiuto di prodotti a cavallo fra le medicine e le droghe, insieme con il ricorso a tutte le variazioni della cura fisica del corpo e del modo di esibirlo all’ammirazione propria e altrui: fitness, palestre, diete, beauty center. Fino a luoghi da considerare come dei veri e propri santuari della salute e della bellezza, mete di pellegrinaggi affollati.
Causa non ultima delle contraddizioni del tempo è stata certamente l’ambiguità enfatizzata da una cultura costantemente oscillante fra il materialismo e lo spiritualismo, terminali patologi del dualismo ellenico fra carne e spirito, che ha condizionato per secoli la cultura cristiana sul corpo, anche con il contributo di alcuni grandi santi, interpreti di una radicale contrapposizione appunto fra corpo e anima. Una cultura che sta agli antipodi di un cristianesimo, definito anche la “religione del corpo”, perché è stata generata dall’Incarnazione e si proietta verso la glorificazione eterna con la Risurrezione del corpo.
In ogni caso, come ha sottolineato il card. Martini: «Non è affatto scontato un rapporto pacifico con il proprio corpo che, sovente, suscita simpatia e insieme a diffidenza. Lo si esalta e lo si denigra, lo si considera come un valore assoluto e lo si legge come carcere dello spirito, dominio della necessità, fonte di dolore» (da “Sul corpo”, Milano 2000, p. 38).
Una cultura che affida all’esaltazione del corpo il ruolo di una iniziazione alla felicità, se non alla immortalità: «Investendo denaro nella ricerca, le scoperte scientifiche accelereranno il progresso tecnologico. Nuove tecnologie daranno impulso alla crescita economica, e un’economia in crescita destinerà ancora più fondi alla ricerca. Decennio dopo decennio, potremmo avere più cibo, veicoli più veloci e farmaci migliori. Un giorno la nostra conoscenza sarà così vasta e la nostra tecnologia così avanzata che distilleremo l’elisir dell’eterna giovinezza, quella della vera felicità e qualsiasi altra droga potremmo desiderare – e nessun dio ci fermerà. (…) Secondo alcuni esperti gli umani saranno in grado di sconfiggere la morte entro il 2200, secondo altri nel 2100» (il punto d’arrivo è nel titolo del libro da cui ho tratto la citazione: “Homo deus. Breve storia del futuro”, di Y. N. Harari, Milano 2017, p. 310).
La pandemia ha rotto lo specchio e ci siamo ritrovati in coda alle migliaia di corpi abbandonati alla morte, privati dell’ultimo saluto, dell’ultimo bacio, dell’ultimo sorriso accompagnato dalle lacrime. Non è necessario aggiungere parole perché tutto questo fa parte del quotidiano da quasi venti mesi a questa parte. Per andare oltre la prospettiva del narcisismo, possiamo e dobbiamo mettere in conto i morti sepolti nelle acque del
Mediterraneo, privati non solo dell’ultimo saluto ma anche della identità, di un nome o di una foto segnaletica. Annegati nell’indifferenza. E possiamo e dobbiamo metterci tutti i corpi dei molti luoghi in cui la sopravvivenza è minacciata dalla guerra e dalla fame.
Ora la pandemia ha smascherato tutte le pretese di autosufficienza.
Nello scorrere dei giorni abbiamo fatto esperienza non tanto di avere un corpo quanto di essere un corpo e quindi non solo di possedere una corporeità che lo situa in un punto mobile dello spazio ma di essere per sé un luogo, per se stesso innanzitutto, ma anche per gli altri. Abbiamo toccato il fondo nell’esplorazione di tutte le nostre fragilità. D’altro canto, tutto questo non basterà a cancellare l’altra faccia della medaglia, quella è rappresentata dallo sviluppo della intelligenza artificiale, della robotica e delle relative applicazioni nella vita quotidiana, con l’inevitabile rimando alla presunzione di immortalità.
Non si tratta di coltivare visioni apocalittiche, ma di esplorare un mondo sconosciuto in cui non possiamo addentrarci senza prendere coscienza dei rischi che ogni scelta comporta. Anche perché è in gioco la natura stessa dell’uomo, come se andasse ancora una volta in onda la scena dell’Eden in cui l’offerta di una mela era accompagnata da una promessa di immortalità: «… quando voi ne mangiaste (della mela – ndr), si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio» (Genesi 3, 5). Nessuno sa la ragione vera che ha indotto Steve Jobs a chiamare Apple (mela) la sua grande intuizione, ma a ben pensarci il collegamento fra le due mele non è astruso (e ha il sapore della presunzione).





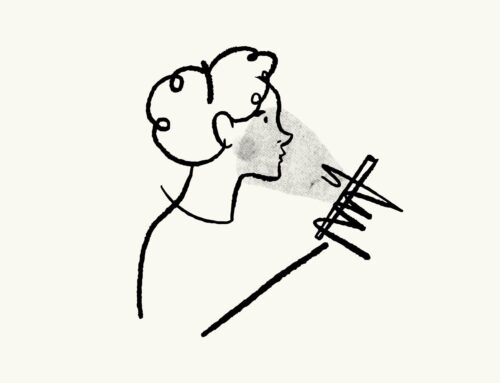


Scrivi un commento